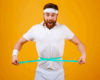Il trapianto di Silvia
|
Un ultimo dell’anno così alternativo non avrei mai potuto organizzarmelo neanche mettendocimi d’impegno. Era la terza volta, nel giro di tre settimane, che, insieme ai miei, percorrevo quei 350 km d’autostrada tutte curve e gallerie che mi separano da Pisa. La prima volta il pancreas arrivato non era idoneo al trapianto. La seconda volta l’organo è stato assegnato ad un’altra ragazza chiamata insieme a me, perché è risultata più compatibile di me. Era la terza volta che vivevo tutta la preparazione all’intervento: l’arrivo, gli ultimi esami, la doccia, l’attesa dell’organo e del parere dei chirurghi, il cross match finale tra il mio sangue e quello del donatore. Ogni volta ero combattuta tra la paura per l’operazione, la felicità per la nuova vita che speravo sarebbe arrivata e il pensiero che in quello stesso momento, in cui io e la mia famiglia speravamo, un’altra famiglia come la mia stava provando il dolore più grande che si possa provare. Uomo, 38 anni, di Asti (piemontese come me!). Questo è tutto quello che ho saputo di lui e tutto quello che m’interessava sapere. Ancora adesso penso spesso con gratitudine a quell’uomo e alla sua famiglia: la loro capacità di amare mi ha permesso di iniziare una nuova vita. Alle 13.00 scendo nei reparti operatori. Il tempo di attendere l’esito finale del cross match e alle 14.00 entro in sala operatoria. Mi addormento quasi subito. Esattamente alle 21 della notte del 31 dicembre 2003, quando fuori iniziano i cenoni e i veglioni di San Silvestro, io mi risveglio (si fa per dire!) in una stanza del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa.. Eppure sono felice….. mezza intontita e dolorante, tagliata, con tubi, cateteri, tubicini, sondini, cannule ovunque, ma felice. Non riesco a vedere le lancette dell’orologio sulla parete di fronte a me passare allineate sul dodici. Sono le 23.50, Sta arrivando il nuovo anno: resto sveglia per salutarlo. Solo il tempo di pensare questo e poi eccomi trascinata di nuovo nel sonno profondo dell’anestesia e dei calmanti. La volta successiva che mi riprendo l’orologio segna già le 00.15. Nessun brindisi, nessun bacio benaugurante sotto il vischio, nessun augurio: solo un infermiere sconosciuto sempre accanto a me, come un angelo custode, molto attento. Chissà se rimpiange comunque qualche festa con gli amici o in famiglia. E invece è lì, ad assistere me. Non pensavo fosse così “difficile”. Ho i tubi dell’ossigeno che entrano nel naso ed un sondino gastrico che ne esce, penzolando per decine di cm all’esterno, rendendo il mio profilo abbastanza simile a quello di un elefante. E’ fissato al naso con un cerotto dall’odore nauseante e, dopo cinque giorni, non lo sopporto più. Eppure mi impedisce di vomitare, cosa che sicuramente accadrebbe di continuo i primi giorni dopo l’intervento, e con un taglio fresco non sarebbe piacevole. Il sondino dal naso scende fino allo stomaco e serve a svuotarne il contenuto tramite aspirazione. Dopo un intervento all’addome di questo tipo lo stomaco e l’intestino non lavorano più per giorni. Solo dal sesto giorno ho iniziato a sbocconcellare una fetta biscottata senza sentire la nausea. La voglia di mangiare è arrivata solo al nono giorno. La mia vicina di letto, invece, ha vomitato per 12 giorni. Su un polso ho l’accesso per il prelievo arterioso per il controllo dei gas nel sangue. La mano è gonfissima, deforme, ogni forma umana scomparsa: sembra una palla con cinque tozze strane appendici. Chissà se tornerà mai normale, mi chiedo. Ha ripreso il suo solito aspetto solo sette giorni dopo l’intervento. Sul collo c’è il catetere principale attraverso cui, per giorni, mi hanno infuso antirigetto, cortisone, eparina, insulina, antidolorifici, glucosio, sali, liquidi, antibiotici, ecc…. L’ho tolto dopo otto giorni, quando ormai iniziava a dolorare. La ferita è un taglio verticale che parte dallo sterno, sotto l’attaccatura del seno, scende, fa un giro intorno all’ombelico e continua la sua discesa fino al pube: un bel ricamino! Non so come sarà esteticamente: ci vorranno almeno sei mesi di tempo per capire quale sarà il mio aspetto futuro. Ma in quel momento, e anche ora, per la verità, è l’ultimo dei miei pensieri. Mi ero preparata e la cosa che conta più di tutte è raggiungere l’insulinoindipendenza, segno che il pancreas funziona. Dalla ferita escono tre tubi di drenaggio per la ferita. Sono quelli che mi causeranno fortissimi dolori quando li toglieranno. Probabilmente uno di quei tubi appoggiava su un nervo, mi diranno. Tutti gli altri operati insieme a me non hanno sentito altro che un po’ di fastidio. “Sembra che il pancreas abbia iniziato subito a lavorare” mi dice sorridente Boggi mentre mi trovo in terapia intensiva. O forse non è Boggi. L’avevo visto solo un paio di volte e la mascherina gli copre quasi tutto il volto. O forse sto sognando, ancora abbandonata allo stordimento del cocktail di antidolorifici che mi stanno facendo. Ricordi vaghi e confusi di quei giorni, persi nella nebbia; efficace, però, quel cocktail perché la ferita non fa male. Uno dei miei timori è stato scongiurato. “Il pancreas sta lavorando”. Ma allora perché tra le migliaia di pompe per infusione endovenosa cui sono attaccata ce n’è una con su scritto “insulina”? “E’ considerato compatibile con la condizione di pancreas funzionante somministrare insulina per i primi 15-20 giorni dopo il trapianto, fino ad un dosaggio di 30 unità al giorno”. Io sono ampiamente sotto quel limite. Ma non mangio ancora niente e le glicemie toccano ancora i 280. Sapevo che sarebbe potuto succedere. La mia amica Daniela mi aveva informata, tramite mia mamma mi dice di stare tranquilla. La ripresa è faticosa e lenta. L’equipe medica e paramedica è competente, professionale ma anche eccezionale dal punto di vista umano. Ogni caso è seguito con la massima attenzione, personalizzando terapie e tempi di recupero e di disinserimento di sondini, cateteri e tubi. Fare confronto con i vicini non ha senso: ognuno ha i suoi tempi e i suoi punti critici. Per quanto mi riguarda, devo dire di aver avuto il migliore decorso operatorio possibile. Mi ci è voluto solo qualche giorno in più per via della forte anemia che ha richiesto quattro trasfusioni, ferro in endovena e eritropoietina. Nonostante questo, il mio trapianto di pancreas è stato un intervento complesso, delicato e impegnativo per me. Mi sento un neonato che deve imparare a fare tutto: costa fatica imparare di nuovo a bere, a mangiare, riprendere a digerire, riprendere il funzionamento dell’intestino. Costa fatica imparare di nuovo a parlare, ad alzarsi sul letto, a camminare, ad andare fino al bagno per lavarsi i denti. Fino ai primi cinque giorni dall’intervento tutte queste piccole banali operazioni sembrano delle eroiche imprese. E io non ho avuto nessuna delle possibili complicanze dell’intervento. Il mio vicino di stanza, addirittura, ha rischiato la vita: un’emorragia prima, per cui hanno dovuto operarlo di nuovo il giorno dopo, e poi liquidi nei polmoni ed un’embolia polmonare. Il pronto intervento dei chirurghi e del personale della rianimazione lo ha salvato. L’intervento non va sottovalutato ma, una volta superati i primi difficili giorni, resta dentro la gioia immensa di non essere più diabetica. Tutto il resto, la forma fisica, si recupereranno alla svelta in seguito. Eppure il quarto giorno dopo l’intervento mi sento così provata, spossata che per una sera penso che non ne valga la pena. Ho detto a mia mamma: “Se avessi saputo cosa m’aspettava dopo, non so se avrei scelto il trapianto”. Anche perché il pancreas aveva iniziato a lavorare ma ancora facevo insulina……… Avevano provato il secondo o il terzo giorno, dopo un paio di glicemie più basse, a ridurre la dose di insulina ma poi erano dovuti tornare al dosaggio iniziale. La mia vicina di letto non faceva più insulina dal giorno successivo all’intervento. Come l’invidiavo. Lei poteva essere certa che il suo trapianto era riuscito. Non vuoi pensarci ma, dietro a tutti i tuoi pensieri, resta come un’ombra scura l’idea che potrebbe essere stato tutto inutile: tutto il dolore, tutte le corse in automobile da casa a Pisa e viceversa, tutte le ore di sonno perse, tutti i ricoveri e gli esami, tutta la preparazione medica e psicologica che avevo fatto per questo intervento….. La mattina del 5 gennaio, lunedì, mi staccano per un’ora dalla pompa di insulina per farmi sedere un po’ in poltrona. Vogliono farmi uno stick, come chiamano qui la glicemia capillare, prima di riattaccarmi a quel liquido che da anni era ormai la mia salvezza e la mia schiavitù. Credo che solo un diabetico possa capire il rapporto di odio – amore che si instaura tra lui e l’insulina. “72! Ti togliamo l’insulina!” Da quel mattino del 5 gennaio io non ho più fatto insulina. C’è voluto qualche giorno perché io e il nuovo pancreas andassimo d’accordo, forse ho ricevuto un pancreas dalla ripresa lenta, un po’ come me, ma, una volta che si è ambientato nella sua nuova casa e ha deciso che ci si trova bene, ha iniziato a svolgere il suo lavoro in modo impeccabile. “Ha il pancreas che è un cannone” mi dice il dottore mentre esegue l’ecografia di controllo. La sensazione era strana: non ero ancora in forma, iniziavo appena a riprendere il controllo delle funzioni vitali del mio corpo, quel controllo che sette ore di anestesia e l’intervento all’addome mi avevano tolto. Mangiavo quello che volevo (per la verità pochissimo i primi giorni) e quando volevo, così mi avevano detto di fare. Ma 13 anni di certi ragionamenti non si cancellano in un giorno. Mi sorprendevo ad interrogarmi sugli effetti di un biscotto sulla mia glicemia o a calcolare quanta insulina avrei dovuto fare per contrastare gli effetti del cibo che stavo per introdurre. La gioia, quella vera, mi è esplosa dentro una notte insonne, trascorsa a seguire l’alternarsi dei movimenti delle nuvole e della luna calante. “Ce l’ho fatta!” Non riuscivo a pensare ad altro. Avrei voluto gridarlo a squarciagola per il corridoio, aprire la finestra che dà sulla pineta e urlarlo alle gazze ladre addormentate. “Dal diabete per ora non si guarisce”. Mi dissero 13 anni prima. Che poi è la cosa che dicono ancora adesso i medici ai nuovi diagnosticati. Ma, cavolo, quello che io sto vivendo è molto simile ad una guarigione! Niente più insulina, niente glicemie alte a tradimento, niente ipo, niente dieta, nessun calcolo logaritmico integrale sui carboidrati e sulle unità di insulina prima di ogni pasto, nessuna umiliante visita per la patente in Commissione Medica Legale, nessuna paura per le complicanze ad ogni nuovo esame di controllo…. gli occhi, i reni, i nervi…… Ad amplificare la mia gioia e la mia eccitazione contribuiva la consapevolezza che quella “guarigione” del corpo era stata preceduta ed accompagnata dalla guarigione della psiche. Io sono “guarita” dal diabete prima nella testa e poi nel corpo. In 13 anni avevo passato tutte le fasi: stupore, incredulità, indifferenza, rabbia, ribellione, accettazione. Avevo elaborato il lutto del mio diabete, lo avevo guardato dritto negli occhi senza paura di scoprire cose di me che neanche io volevo sapere, avevo imparato dalle mie glicemie ballerine tutto quello che potevano indicarmi. L’ultimo insegnamento, quell’ultimo tassello del puzzle che ancora mi mancava per completare il quadro, l’avevo colto un mese o due prima. Adesso mi sentivo pronta per continuare la mia strada senza più la “guida” delle glicemie che fino ad allora mi dicevano quando ero in pace con me stessa e gli altri e quando no. Non è strano. C’è una stretta correlazione, un’influenza reciproca tra andamento delle glicemie e stato d’animo, spiegabile anche scientificamente. Avevo reso superflui i miei sintomi perché ero andata alla vera radice della malattia…. almeno a livello psichico. Ora ero voluta andare alla radice della malattia anche sul piano fisico. Avete mai avuto la sensazione di sapere esattamente dove vi trovate? La certezza di conoscere ogni singolo passo che vi ha portato fino a quel punto e di vedere, come in un’anteprima, i prossimi passi che farete? E i miei prossimi passi, quella notte, erano tutti all’insegna della felicità, della libertà e del rinnovato amore per me stessa. Ho riflettuto in questi giorni sulla mia esperienza personale e sull’opportunità o meno di ricorrere al trapianto di pancreas. Di sicuro il trapianto, per come è ora, non è la cura che tutti i diabetici aspettano da tempo. Non si può praticare a cuor leggero ad ogni nuovo caso di diabete. Per ora la prima scelta della terapia resta l’insulina. Solo nei casi in cui, con il tempo, l’insulina si dimostri inefficace nel contrastare gli effetti devastanti del diabete sul corpo, allora si può pensare al trapianto. Secondo me, non si può pensare al trapianto di pancreas solo perché si è stanchi di fare la dieta e l’insulina. Col trapianto, se riesce, si diventa insulinoindipendenti ma non si torna ad essere sani come prima del diabete. Un trapiantato, soprattutto all’inizio, deve comunque prestare a se stesso molte attenzioni. Sto iniziando ora a capire che cosa voglia dire il post-operatorio e quali siano le regole della mia nuova vita, almeno per questi primi sei delicatissimi mesi. Prendo 35 pastiglie al giorno, divise in quattro assunzioni. Qualche effetto collaterale prima o poi verrà fuori. Sono a forte rischio infezioni per l’immunosoppressione: evitare luoghi chiusi e affollati, rapporti interpersonali ravvicinati, mettere la mascherina. Aumenta il rischio di tumori alla pelle, anche se di poco. Per evitare ulteriori rischi, in caso di esposizione al sole meglio usare una crema a protezione totale. L’intestino è stato tagliato e cucito in più punti per drenarvi i succhi pancreatici. Per i primi sei mesi non devo mangiare né frutta né verdura, per evitare le occlusioni intestinali, e, anche dopo, sarà difficile tornare a mangiare quei piattoni unici di insalata cruda che mangiavo la scorsa estate. I controlli, soprattutto all’inizio, si intensificano. Il trapianto non è la cura perché è un intervento rischioso per le complicanze (emboli, trombosi, emorragie, ecc…) e comporta un decorso post-operatorio delicato e pesante per il paziente. Perché comporta l’assunzione a vita di immunosoppressori che aumentano lievemente il rischio di tumori alla pelle e di linfomi e, se il diabete non è complicato, non è il caso di esporsi a questi rischi. Perché il risultato non è certo, anche se, negli ultimi anni, le nuove tecniche chirurgiche, un’accurata selezione di donatore e ricevente e nuovi farmaci immunosoppressori hanno migliorato nettamente le statistiche di sopravvivenza dell’organo. Il rigetto può essere acuto, subito dopo l’intervento, ma può sempre avvenire, più frequentemente nel primo anno. Comunque la durata dell’insulinodipendenza non è nota. Tutti questi rischi e inconvenienti sono giustificabili solo se, sull’altro piatto della bilancia, ci sono problemi medici concreti, le complicanze del diabete, non pochi anni di diabete, una glicata di 6% e nessuna complicanza ma solo la non accettazione psicologica della malattia. Chi non accetta il suo diabete, faticherà anche ad accettare le conseguenze del trapianto. Tra le indicazioni al trapianto di pancreas spesso si legge anche “gravi difficoltà psicologiche ad accettare la malattia”. Prima del mio trapianto, potevo anche condividerlo. Ora non più. Se il problema è psicologico, si lavori sulla psiche e, solo dopo, se permangono problemi medici nel trattare il diabete, si pensi al trapianto di pancreas. Il trapianto di pancreas, però, non dovrebbe neanche essere l’ultima spiaggia del diabetico complicato. Arrivare al trapianto di pancreas o di rene-pancreas con nefropatia conclamata irreversibile, magari dopo qualche anno di dialisi, con gli occhi rovinati, con la neuropatia, con danni irreversibili a tutti i tessuti, non ha senso: aumentano i rischi dell’intervento, la ripresa è molto più complicata, viene meno uno dei benefici principali del trapianto di pancreas che è quello di bloccare l’evoluzione delle complicanze. Senza contare che il diabete può causare danni cardiovascolari tali da controindicare il trapianto. Eppure, ancora oggi, tranne in alcuni centri come quello di Pisa, il trapianto di pancreas è proposto solo insieme a quello di rene, dopo che si è tentato di tutto e di più con le terapie tradizionali e non se ne viene fuori lo stesso. Dopo la mia esperienza, resto della mia opinione in base alla quale ho fatto la mia scelta personale. Il momento giusto per il trapianto di pancreas è la comparsa delle prime molteplici complicanze del diabete. A quel punto i medici dovrebbero proporre due opzioni terapeutiche: le terapie convenzionali e il trapianto di pancreas, già subito, senza aspettare danni ulteriori. Sarà il paziente a scegliere, insieme ai suoi medici. Oggi questa scelta non è offerta, non a questo punto della malattia. E’ il paziente che si informa che lo propone al diabetologo. Così ho fatto io. La mia scelta è stata di non accanirmi per altri anni con le terapie convenzionali. I rischi dell’evoluzione di tre complicanze ormai certe bilanciano ampiamente e superano i rischi dell’intervento e dell’immunosoppressione.
|
|
Silvia Demartini, primavera 2004 |